La mattina in cui la professoressa C. decise di cambiare metodo, nulla lo lasciava presagire. Aula al piano terra, luci al neon ancora troppo bianche, un odore di pioggia portato dentro dagli zaini. Luca, sedici anni, il cappuccio che scivola sugli occhi, entra in ritardo, si siede in fondo e lancia un sorriso ironico ai compagni. La prof gli chiede il motivo, lui risponde con quell’atteggiamento tipico dell’adolescenza: “Non è affar suo”. Breve gelo, mormorio. Il copione di sempre sarebbe stato una reprimenda, un richiamo al registro elettronico, il piccolo teatro della disciplina. Invece, quel giorno, la prof chiese alla classe di leggere in silenzio tre pagine di un autore che non capivano ancora; poi si sedette accanto a Luca e gli chiese se dormisse la notte. Lui fece spallucce. Lei aggiunse una domanda diversa: “Chi, a casa, conta sul fatto che tu ti alzi presto?” Non fu una confessione, fu una piega del viso. Il padre, turni all’alba. Il fratellino, da accompagnare. Da quel margine, la lezione cambiò direzione. Non fu un atto di bontà, né una tregua paternalistica; fu il riconoscimento che l’insegnamento non è trasferimento di contenuti dall’alto, ma un incontro nel quale ciascuno mette in gioco precomprensioni, attese, fraintendimenti. E da lì si cominciò a leggere, davvero.

Se c’è un filosofo che ha reso esplicito questo nucleo elementare – il fatto che ogni atto educativo è un evento interpretativo – è Gadamer. Per lui, comprendere non è decifrare un codice ma prendere parte a un’esperienza che ci coinvolge come interlocutori, con tutto il peso delle nostre abitudini e dei nostri pregiudizi, intesi non come vizi morali ma come condizioni storiche dell’intesa. L’educazione, in questa prospettiva, non è una procedura con esiti garantiti; è una pratica di ascolto e risposta nella quale l’altro, proprio perché è altro, può spostare il baricentro del nostro sguardo. La professoressa C., quel giorno, ha sospeso l’idea del controllo per accogliere l’imprevisto, che è poi il luogo in cui la formazione accade.
Gadamer insiste su una parola che la scuola contemporanea tende a pronunciare poco: formazione, Bildung. Non è l’accumulo progressivo di nozioni, ma una modulazione della nostra capacità di giudicare, di vedere i nessi, di accostare il particolare al tutto e il tutto al particolare. La Bildung non è una conquista definitiva: si svolge come una pratica di cura del giudizio, affine alla “tatto” educativo, a quella sensibilità discreta che permette di scegliere il gesto giusto senza poterlo dedurre da una regola universale. È il contrario tanto del sentimentalismo quanto del legalismo, perché accetta l’idea che l’intelligenza pratica non si riduca a protocolli. Nel caso della professoressa C., il tatto non è stato un cedimento, ma l’arte di trovare la distanza adatta per aprire un dialogo, senza rinunciare alla responsabilità della valutazione. In questo senso, l’educazione è sempre anche autoeducazione: si cresce facendo spazio a ciò che il confronto ci costringe a rivedere.
Nel nostro lessico istituzionale, dove performance e accountability hanno preso il posto di parole più antiche, l’idea di educazione come accadere interpretativo può sembrare evasiva. Eppure, è precisamente qui che la prospettiva ermeneutica acquista concretezza. L’insegnante non è un distributore di unità didattiche, ma un interlocutore che promuove la fusione – mai compiuta – di orizzonti. L’orizzonte dell’autore, l’orizzonte degli studenti, l’orizzonte del presente istituzionale, con i suoi vincoli e le sue retoriche. In classe, non ci si limita a mettere in contatto queste linee di forza: si chiede agli studenti di farle reagire. L’interpretazione non è arbitrio; è l’impegno a rendere ragione delle proprie letture alla luce di un testo che resiste, di domande che inquietano, di argomenti che pretendono di essere ascoltati. Qui la valutazione smette di essere pura sanzione e diventa un esercizio di responsabilità condivisa.
Il cuore del problema è che la scuola ha spesso interiorizzato l’idea che l’apprendimento consista nell’azionare correttamente strumenti. Ma chi ha provato a spiegare un verso difficile o una proporzione matematica sa che lo strumento, da solo, non decide nulla. L’interpretazione è un “gioco” serio – Gadamer usa proprio la categoria del gioco – che ci trascina e ci espone; e proprio perché ci trascina, non siamo noi a controllarlo fino in fondo. In aula, il gioco dell’interpretazione accade quando un’osservazione di un ragazzo costringe l’insegnante a riformulare la domanda, quando un esempio sgangherato illumina l’argomento meglio di una definizione perfetta. Questa dimensione non è un orpello umanistico: è la sostanza dell’apprendere. Chi riduce l’educazione a trasmissione ignora che si diventa adulti quando si scopre che nessun sapere serio esiste senza il rischio di capirsi di più o di capirsi meno.
Si dirà che tutto questo è bello, ma inefficiente. L’obiezione merita rispetto, perché viviamo in sistemi educativi sottoposti a una pressione costante: monitoraggi, scadenze, classifiche. Tuttavia, l’inefficienza dell’ascolto è la sola strada che evita inefficienze più gravi. Quando la professoressa C. ha rinunciato alla scenetta del rimprovero, non ha perso tempo: ha evitato di consolidare un ruolo, quello del “cattivo” e del “buono”, che avrebbe reso impossibile ogni apprendimento successivo. In un orizzonte gadameriano, i ruoli non scompaiono, ma si riconfigurano nel dialogo. L’autorità non coincide con l’autoritarismo; viene riconosciuta perché si mostra capace di offrire ragioni e di accettare, a sua volta, la prova delle ragioni altrui. È una concezione esigente, perché chiede ai docenti di comparire in aula non come funzionari della spiegazione, ma come soggetti che hanno a cuore la verità dei processi nei quali, con gli studenti, si mettono in gioco.

Questa immagine ha anche conseguenze sulla maniera di trattare i testi. Non si legge per estrarre tesi, ma per apprendere una postura, un modo di stare di fronte al significato. L’idea che ogni comprensione autentica sia anche applicazione toglie all’interpretazione la sua aura scolastica: capire un lemma giuridico è già cominciare a misurare la sua forza nel mondo; comprendere un passo di filosofia è già interrogarsi su come esso giudica i nostri criteri. La lettura, così, diventa un laboratorio in cui si fa esperienza di libertà vigilata: libertà di proporre, vigilanza del testo che costringe a tornare indietro, a limare, a cambiare accento. La professoressa C. ha fatto proprio questo quando ha legato la fatica di Luca a un problema di responsabilità, non di psicologia: a chi devi rispondere? In che misura la tua scelta pesa sugli altri? Domande che il testo in programma ha saputo provocare, non perché offrisse esempi pronti, ma perché la classe si è disposta a lasciarsi mettere in questione.
Nella grammatica di Gadamer, i pregiudizi non sono nemici da estirpare ma posizioni preliminari da revisionare alla luce dell’incontro. Questo vale anche per i pregiudizi degli insegnanti. È un punto scomodo, e quindi utile. Ogni docente porta in aula una storia di successi e delusioni, di modelli ricevuti, di entusiasmi spesi male. Se non diventa consapevole di questo bagaglio, lo imporrà senza saperlo, trasformando la lezione in un monologo. L’ermeneutica, al contrario, invita a esercitare un’auto-sospensione vigilante: mi fermo, ascolto, mi lascio contraddire, ma non abdico alla responsabilità di decidere quando è il momento di stringere l’argomento o di allargarlo. È un equilibrio fragile, che richiede formazione continua e un’etica professionale non riducibile ai regolamenti. Proprio qui la categoria di Bildung mostra la sua carica critica: essere formati non equivale a possedere un bagaglio, ma a maturare una disponibilità a rimettere in ordine quel bagaglio davanti a ogni nuovo incontro.
Viene allora un dubbio: non rischiamo di romanticizzare l’insegnamento, di pretendere da ogni ora ciò che in realtà accade solo poche volte in una carriera? Il rischio esiste. Ma il punto non è trasformare ogni lezione in un’epifania, bensì cambiare la soglia di attenzione. Se la scuola assume davvero che l’apprendimento avviene nell’interazione viva di interpretazioni e di voci, allora organizzerà tempi e spazi perché ciò sia possibile. Non servono eroismi, serve riconoscere che i momenti “vuoti” sono in realtà tempi di decantazione, e che l’ossessione per la copertura del programma tradisce un’idea dis-incarnata di sapere. Nessuno propone l’anarchia: si propone una responsabilità più esigente, che lascia accadere la comprensione e, insieme, la verifica con rigore. È una responsabilità che riguarda anche gli studenti, chiamati a presentare le loro ragioni, a distinguere il gusto dalla prova, il sentito dire dall’argomentato.
Tutto ciò richiede un patto rinnovato tra scuola e società. Perché l’ermeneutica non è un vezzo teorico, è una politica della conoscenza. In un’epoca satura di spiegazioni immediate, di tutorial che promettono scorciatoie, l’educazione che forma davvero è quella che ci rende lenti quando serve, curiosi quando la fretta ci tenta, coraggiosi quando l’incertezza ci infastidisce. La professoressa C. non ha concesso un privilegio a Luca; ha riconosciuto che la verità dell’aula si gioca nelle condizioni reali in cui ciascuno arriva a lezione. Non si tratta di psicologizzare la didattica, ma di riconoscere che l’interpretazione è sempre situata, e che l’idea stessa di comprendere implica un’applicazione al presente. Qui la pedagogia gadameriana smette di essere contemplativa: l’incontro educativo diventa, ogni volta, un esperimento di cittadinanza culturale.

Forse il lascito più concreto di questa prospettiva è una virtù poco appariscente: la disponibilità a farsi sorprendere. Non è spontaneismo. È la consapevolezza che l’intelligenza critica non nasce dal sospetto sistematico, ma dall’arte di porre domande vere, quelle che mettono a rischio l’ipotesi da cui siamo partiti. In un tempo che misura la qualità della scuola a colpi di indicatori, la sorpresa è un bene sospetto; eppure è l’unico motore affidabile dell’interesse. Il giorno dopo, Luca arrivò puntuale. Non per gratitudine, ma perché qualcuno aveva capito che la sua resistenza non era solo maleducazione; era una richiesta mal formulata di senso. Di quel senso, la letteratura che stavano leggendo non offriva risposte facili, ma un ventaglio di possibilità. È molto. È abbastanza per tornare in aula con un’idea meno povera di che cosa sia “capire”.
Riletta così, la scena iniziale non è un apologo edificante. È una messa in prova della teoria. L’ermeneutica non promette magie, ma indica una via di realismo educativo: fare i conti con il fatto che gli esseri umani apprendono in condizioni d’attrito, tra parole che non combaciano e attese che si contraddicono. Quel che chiamiamo educazione è la scelta, sempre reiterata, di stare dentro a questo attrito senza cinismo, con quella misura che Gadamer chiama formazione del giudizio. È una scelta che non produce testate giornalistiche, non fa rumore nelle classifiche, ma prepara cittadini capaci di argomentare senza umiliare, di cambiare idea senza sentirsi sconfitti, di dare peso alle parole quando le parole scarseggiano. In un mondo che chiede alla scuola di “funzionare”, questa può sembrare una promessa modesta. È invece l’unica all’altezza di un’istituzione che, ogni mattina, prova a trasformare una stanza chiusa in un luogo di mondo.
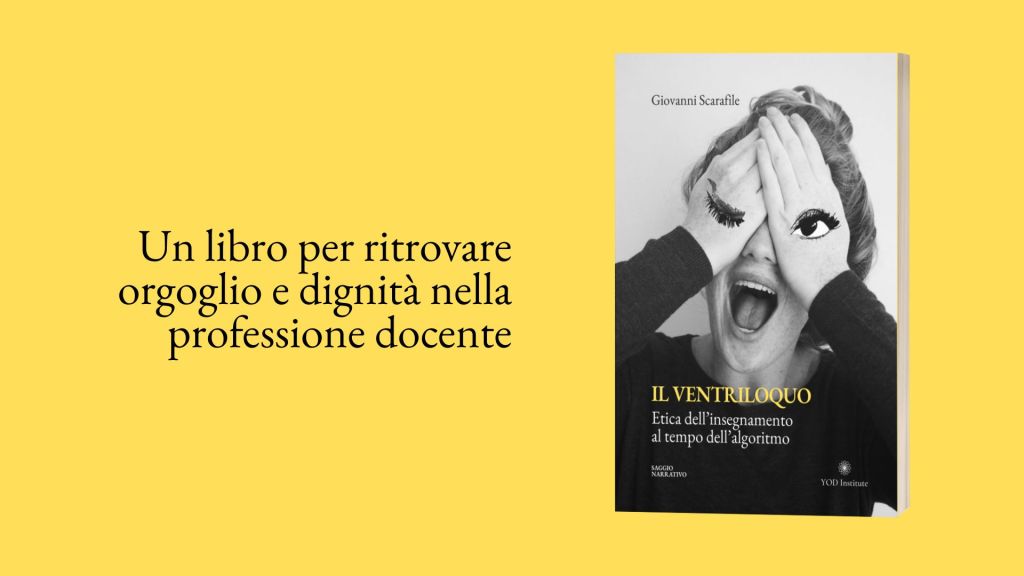

Lascia un commento