1. Via negativa e conoscenza per sottrazione
Vitantonio era il nome dell’anziano fotografo da cui mio padre si recava alla metà degli anni Settanta per acquistare i rullini. Di quell’uomo mi rimane in mente ancora un’immagine piuttosto nitida: alto, sottile come un giunco, con occhiali dalla montatura scura – nera, o forse grigio fumo, non saprei giurarlo. Per qualche imperscrutabile alchimia della memoria infantile, il suo volto rimane indissolubilmente legato agli ami da pesca e alle schedine del Totocalcio: erano queste le materie di cui “i grandi” discutevano con gravità sacerdotale, mentre io, cinque o sei anni appena, restavo incantato davanti alle vetrine come fossi al cospetto di reliquie. Lo studio era piccolo, quadrato, una stanza sospesa in un tempo parallelo: un armadietto pieno di macchine fotografiche che sembravano congegni da laboratorio alchemico, lenti che catturavano la luce, cornici dorate; e dietro – chissà, non osavo nemmeno immaginarlo – la camera oscura, quel regno proibito e magnetico in cui la luce si trasformava in memoria.

Poi arrivò la Polaroid. Credo di averla ricevuta per la Comunione, forse perché qualcuno pensò che miracoli istantanei fossero più adatti a un bambino. Anche allora bisognava passare da Vitantonio, stavolta per le pellicole. Ma il mistero si era sgretolato: la foto usciva subito, ancora umida e lattiginosa, pronta all’istante. E con quella fretta – bisogna ammetterlo – si perdeva tutta quella sacra, interminabile attesa che un tempo faceva parte del rito della rivelazione.
Un giorno mi trovai tra le mani un negativo, uno di quelli tradizionali. Una sottile striscia di pellicola che, portata controluce, mostrava i volti rovesciati in ombre, i sorrisi tracciati come segni scuri, il giorno trasfigurato in un buio fitto. Era fragile, quasi inconsistente, eppure senza quella immagine capovolta non vi sarebbe stata alcuna fotografia, nessuna restituzione del reale sulla carta.
Fu, quella, un’esperienza semplice e comune, ma capace di indicare cosa significhi via negativa: non guardare la realtà nel suo volto immediato, bensì raggiungerla attraverso la sottrazione; non dire affermando, ma dire togliendo; non definire, ma serbare in silenzio ciò che ancora non si mostra, nell’attesa che, solo dopo, venga finalmente alla luce.
2. Dal dis-astro all’urgenza teologico-politica dell’umano
Se quel negativo fotografico mi aveva insegnato che il senso talvolta si custodisce nel rovescio, allora anche parlare dell’uomo diventa impresa simile.
Mi spiego: un tempo, dire Dio era già difficile: i mistici medievali, da Dionigi l’Areopagita a Meister Eckhart, avevano compreso che l’unica via era sottrarre, dire ciò che Dio non è.
Oggi, in un tempo segnato non dal mistero della trascendenza ma dal disincanto delle rovine – in un passaggio dal sub specie aeternitatis al sub specie ruinarum[1]— la frequenza con cui l’umano viene esposto al rischio di dissolversi ci costringe a imboccare la stessa via: quella negativa.
Non più e non solo la rassicurazione delle definizioni – animale politico, produttore di senso, essere di linguaggio – ma un esercizio di sottrazione, un “non è questo” ribadito ogni volta che il disastro si traveste da normalità. In questo senso, la via negativa della resistenza non si limita a non proclamare cosa l’uomo sia, ma custodisce con vigilanza ciò che non deve mai essere ridotto, ciò che non può essere abbandonato alle formule di gestione e ai lessici dell’amministrazione.

In questo senso, l’idea di “urgenza dell’umano” non può essere compresa come un appello morale di tipo tradizionale, una voce in più accanto alle molte che già reclamano attenzione su diritti, doveri, emergenze. A distinguere l’urgenza è piuttosto la sua natura radicale, che la colloca nel registro di una vera e propria categoria teologico-politica. La sua forza non risiede nell’aggiungere un nuovo argomento al dibattito, ma nell’obbligare il discorso a misurarsi con ciò che non si può rinviare.
Non si tratta dunque di ripristinare la trascendenza in un’epoca che da tempo l’ha smarrita. Non siamo più nel mondo simbolico in cui Dio costituiva l’orizzonte ultimo della parola e del pensiero. Ma qualcosa di ciò che un tempo veniva attribuito a Dio rimane, e oggi si manifesta nell’umano: l’impossibilità di ridurre tutto a calcolo, l’improrogabilità di ciò che conta, l’irriducibilità di certe esigenze a essere catturate dalle logiche della gestione. È qui che prende forma la categoria di urgenza, come eredità secolarizzata di un tratto che, nella tradizione teologica, era riconosciuto al divino.
Non possiamo più fingere che si tratti di normali difficoltà professionali o di temporanee disfunzioni del sistema. Siamo di fronte a un’urgenza dell’umano che richiede la possibilità stessa di un’educazione degna di questo nome. Lo stato di urgenza non è una metafora apocalittica, ma la descrizione precisa di una situazione in cui l’eccezione – la mercificazione totale del sapere, la riduzione dell’educazione a commodity, la trasformazione del docente in erogatore di servizi – è diventata la norma.
Il ventriloquo. Etica dell’insegnamento al tempo dell’algoritmo
Dire “urgenza” significa allora imporre al linguaggio una postura performativa e non descrittiva. Non è una parola che si limiti a registrare ciò che accade: è una parola che interviene, che interrompe il continuum delle giustificazioni e delle attese. Spezza il linguaggio della gradualità, quello che promette cambiamenti futuri, progressivi, sempre differiti, e lo sostituisce con un imperativo che non consente rinvii.
Chi ascolta un discorso segnato dall’urgenza non può collocarlo nel registro delle riforme possibili, dei miglioramenti a medio termine, delle soluzioni da valutare con calma. L’urgenza mette di fronte a un fatto: ci sono situazioni in cui il ritardo equivale a complicità. In questi casi, il non-agire non è una sospensione neutra, ma diventa immediatamente corresponsabilità del male che avanza.
3. Normalizzazione del disastro e critica della narrazione emergenziale
La vera malattia del presente è la normalizzazione del disastro. Walter Benjamin, nelle Tesi di filosofia della storia, lo aveva previsto con lucidità: «La tradizione degli oppressi ci insegna che lo «stato di emergenza in cui viviamo è la regola. Dobbiamo giungere a un concetto di storia che corrisponda a questo fatto»[2]. Benjamin intendeva dire che ciò che viene presentato come eccezione – la guerra, la violenza, l’ingiustizia – non è un incidente temporaneo ma la condizione abituale in cui vivono gli oppressi. Lo “stato di emergenza” non è quindi una parentesi che interrompe la normalità: è la normalità stessa. Chiamarlo emergenza serve ai dominatori per mascherare il carattere strutturale della catastrofe e trasformarla in qualcosa di apparentemente inevitabile e accettabile.
Basta guardare al linguaggio con cui i media trattano le guerre: l’invasione russa dell’Ucraina è diventata “il conflitto in Ucraina”, come se fosse un fatto geografico; la distruzione di Gaza viene rubricata a “crisi umanitaria”, come se fosse un incidente meteorologico. Lo stesso meccanismo vale per l’intelligenza artificiale: invece di affrontare la questione di come questa tecnologia stia riplasmando i fondamenti della decisione politica, economica ed educativa, il dibattito si sposta subito sulla “regolamentazione”, cioè sull’amministrazione di un processo già accettato come irreversibile. È il disastro che viene trasformato in dato, l’eccezione che viene integrata come routine. Proclamare l’urgenza dell’umano significa rifiutare questo linguaggio anestetizzante, dire che la catastrofe non può essere normalizzata, che l’ingiustizia non può diventare un’abitudine.
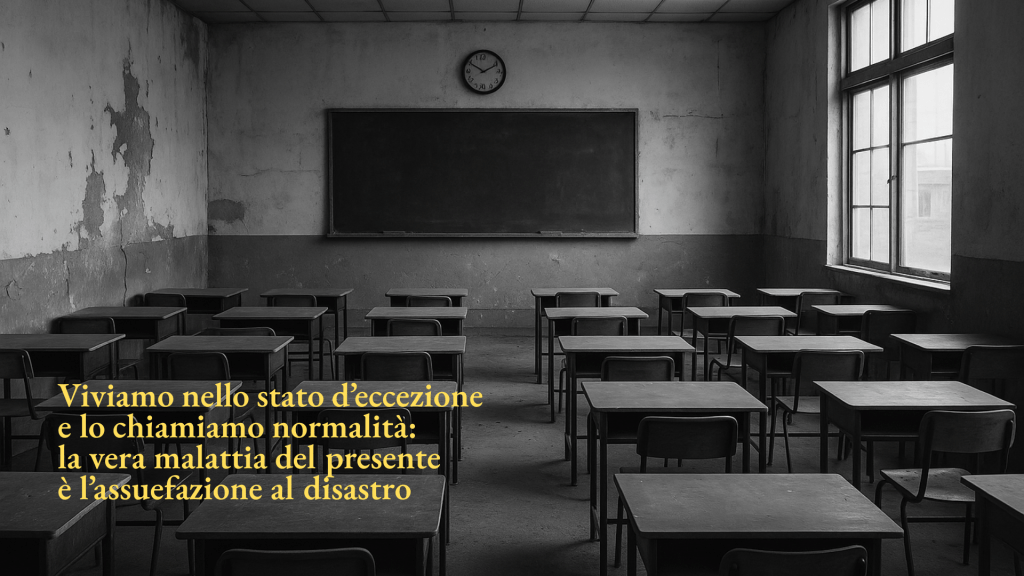
La stessa logica investe la scuola. Anche qui lo “stato di emergenza” non appare come un fatto eccezionale, ma come la condizione ordinaria dell’insegnamento. Si parla di “emergenza educativa”, di “emergenza valutativa”, di “emergenza digitale”: parole che giustificano riforme continue e nuovi adempimenti, imponendo ai docenti un presente senza tregua. La normalizzazione del disastro prende la forma di metriche, report e classifiche che sostituiscono l’atto educativo. In questo quadro, l’insegnante diventa l’oppresso di cui parla Benjamin: costretto a vivere in un’emergenza permanente che lo priva della voce e lo riduce a ventriloquo di procedure e formulari. Applicare il pensiero di Benjamin alla scuola significa allora riconoscere che la vera urgenza è liberare l’insegnamento dalla sua cattura nell’eccezione resa norma, restituendogli la possibilità di un tempo diverso, non amministrato ma aperto al futuro.
E proprio la scuola diventa uno speciale banco di prova. Qui si rende visibile in forma estrema il meccanismo della normalizzazione dell’emergenza: il docente, ridotto a marionetta del sistema, è la figura paradigmatica del “non-umano”. Non perché gli manchi la sua umanità, ma perché il sistema lo priva della possibilità di esercitarla. L’insegnante che recita procedure al posto di pensare, che compila formulari al posto di educare, che subisce metriche invece di stabilire relazioni, rappresenta con crudezza l’esito più inquietante della malattia del presente: l’addomesticamento dell’umano fino a renderlo irrilevante.
4. Oltre il comando: l’eccezione come atto collettivo
Schmitt apre la sua Teologia politica con la celebre formula «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»[3] per mostrare che la sovranità non si manifesta nei tempi ordinari, regolati dalle leggi, ma nel momento estremo in cui le leggi non bastano più. La norma ha senso solo quando c’è una normalità cui applicarla; ma quando sopraggiunge un evento che sfugge a ogni previsione – una guerra, una rivolta, un collasso istituzionale – non è la norma a decidere, bensì la volontà che stabilisce che siamo in uno stato di eccezione e ne determina le conseguenze. È qui che si rivela chi detiene davvero il potere: colui che può sospendere l’ordinamento giuridico pur rimanendo, paradossalmente, parte di esso. Per Schmitt, l’essenza della sovranità non è quindi la norma, ma la decisione, perché è nel caso estremo che l’autorità mostra la sua natura: creare diritto anche sospendendo il diritto stesso.

Ma se si accetta questa diagnosi senza riserve, si finisce per legittimare proprio ciò che ha giustificato innumerevoli derive autoritarie: l’idea che l’eccezione sia appannaggio esclusivo del sovrano. Il problema, allora, non è solo riconoscere la potenza di quella definizione, ma rovesciarne l’esito. L’eccezione non deve restare prerogativa di chi comanda, ma può diventare il gesto di una comunità civile che rifiuta di adattarsi. È in questa prospettiva che Hannah Arendt parlava del potere di inaugurare[4]: non subire il tempo, ma introdurre qualcosa di nuovo. L’eccezione, liberata dalla sua ombra autoritaria, cessa di essere sospensione della legge e diventa possibilità di immaginazione politica, rottura del ciclo riformista che si limita a ritoccare, aggiustare, procrastinare.

Quando si tratta di clima, conflitti o tecnologie pervasive, la logica del piccolo passo non basta più: ciò che serve è una decisione che segni un prima e un dopo. Da quella decisione nasce ciò che possiamo chiamare creatività civile dell’umano. Non creatività come slogan dei laboratori d’impresa, ma come forza politica che inventa forme di vita comuni. Non basta denunciare lo stato d’urgenza: occorre tradurlo in pratiche di convivenza alternative. È il gesto che trasforma la precarietà climatica in nuove modalità di abitare i territori, la devastazione della guerra in reti di ospitalità, l’invasività dell’intelligenza artificiale in strumenti di democratizzazione del sapere anziché di concentrazione del potere.
5. Insegnare non è obbedire
La scuola, in questa prospettiva, è banco di prova privilegiato.
È per questo che nel «Manifesto per il rinnovamento delle coscienze»[5], ho proposto un decalogo che indichi linee di resistenza. Alcuni punti appaiono oggi decisivi per smontare lo stato di emergenza imposto da chi comanda: il recupero della dignità professionale come condizione minima dell’insegnamento; la difesa della voce propria del docente contro il ventriloquio delle procedure; la rivendicazione del pensiero critico come cura necessaria della convivenza democratica.

A queste forme di resistenza si aggiunge lo sciopero ontologico, che non è una semplice astensione dal lavoro, ma la sospensione del ruolo reificato che il sistema attribuisce all’insegnante. È il rifiuto di ridursi a marionetta di metriche e procedure, il gesto con cui il docente sottrae la propria presenza viva alla logica che lo vuole ingranaggio impersonale. Scioperare ontologicamente significa smettere, per un istante, di impersonare il “non-umano” che il sistema scolastico produce, per riaffermare che l’insegnamento è relazione, parola propria, testimonianza. È l’atto con cui l’umano, reificato, torna a manifestarsi come irriducibile.
6. La teologia negativa della resistenza come atto politico
In questo senso, la scuola diventa un laboratorio politico di prim’ordine: lì si decide se l’eccezione resterà strumento di dominio o se diventerà atto inaugurale di una convivenza diversa.
Questa insubordinazione semantica – il dire “no” alla normalizzazione – non è un esercizio retorico, ma forse l’ultimo spazio di libertà che ci resta. Non si tratta di possedere una definizione definitiva di ciò che è l’uomo, perché l’umano non è mai un concetto esauribile: è piuttosto la possibilità che resta aperta, l’eccedenza che nessun dispositivo può catturare. La teologia negativa della resistenza non è un sistema, non è una dottrina da imporre: è un atto. Un atto che non garantisce soluzioni immediate, ma che scava, apre faglie, incrina l’ordine consolidato.
Resistere, in questo senso, significa non lasciare che il linguaggio del potere diventi l’unico vocabolario del presente. Significa custodire parole scomode – giustizia, dignità, verità – che il lessico della governance vorrebbe neutralizzare in “procedure”, “indicatori”, “competenze”. Significa affermare che non tutto può essere tradotto in calcolo, che non tutto è misurabile, che non tutto si lascia amministrare.

Un manifesto di resistenza oggi non ha bisogno di proclami roboanti o di promesse messianiche. Ha bisogno di questo gesto minimo e radicale: non accettare che l’urgenza dell’umano sia derubricata a questione settoriale, a capitolo da collocare accanto ad altri nella lista delle priorità politiche. Proclamare che l’urgenza dell’umano è la condizione stessa perché ci sia ancora politica, perché la convivenza non diventi pura gestione, perché la libertà non si riduca a scelta tra opzioni già decise.
Se c’è una forma non violenta di insubordinazione oggi praticabile, è questa: custodire la possibilità dell’umano come ciò che non si lascia normalizzare, come ciò che continua a sfuggire ai dispositivi del potere. Non un programma da amministrare, ma un atto da ripetere: fragile, ostinato, irriducibile. È forse poco, ma è ciò che ci resta per non rinunciare alla promessa di una vita comune che sia ancora degna di essere chiamata politica.
Bibliografia
Arendt, H. (1998). The Human Condition (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press
Benjamin, Walter. Angelus novus: saggi e frammenti. Tradotto da Renato Solmi. Nuova universale Einaudi 175. Giulio Einaudi editore, 1962.
Blanchot, Maurice. L’écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980
Scarafile, Giovanni. Il ventriloquo. Etica dell’insegnamento al tempo dell’algoritmo. YOD Institute, 2025.
Schmitt, Carl. Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica. A cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera. Bologna: Il Mulino, 2013.
[1] In Blanchot, L’écriture du désastre (Gallimard, Paris 1980), il termine désastre (dis-astro: perdita della stella) non indica in Blanchot una catastrofe empirica, ma una condizione ontologica: la sottrazione di ogni fondamento e orientamento, l’impossibilità di riassorbire l’estraneità del reale in una narrazione o dialettica consolatoria. Il disastro è ciò che dis-viene, che si sottrae alla presenza. Nel contesto di questo scritto, il richiamo istituisce una genealogia della sottrazione: se i mistici medievali sottraevano attributi a Dio per avvicinarsi al suo mistero ineffabile, noi oggi sottraiamo certezze all’umano non per reverenza, ma perché il Novecento ci ha consegnato un campo di rovine in cui l’umano stesso è esposto alla dissoluzione. Il disastro blanchotiano segna così il passaggio dalla teologia apofatica (dire Dio per sottrazione) a un’antropologia apofatica contemporanea: dire l’uomo per sottrazione, in un tempo “senza stella”, tra le rovine di un’immanenza frantumata. Quel disastro è la cifra di questa esposizione permanente: non più il mistero della trascendenza, ma la frantumazione dell’immanenza. La via negativa, allora, si rovescia: non più ascesa verso l’indicibile, ma discesa tra i frammenti, tra ciò che resta quando anche il “negativo fotografico” della realtà si oscura.
[2] Benjamin, Angelus novus.
[3] Schmitt, Teologia politica.
[4] Arendt et al., The Human Condition. La frase rilevante è: «since action is the political activity par excellence, natality, and not mortality, may be the central category of political, as distinguished from metaphysical, thought».
[5] Scarafile, Il ventriloquo. Etica dell’insegnamento al tempo dell’algoritmo
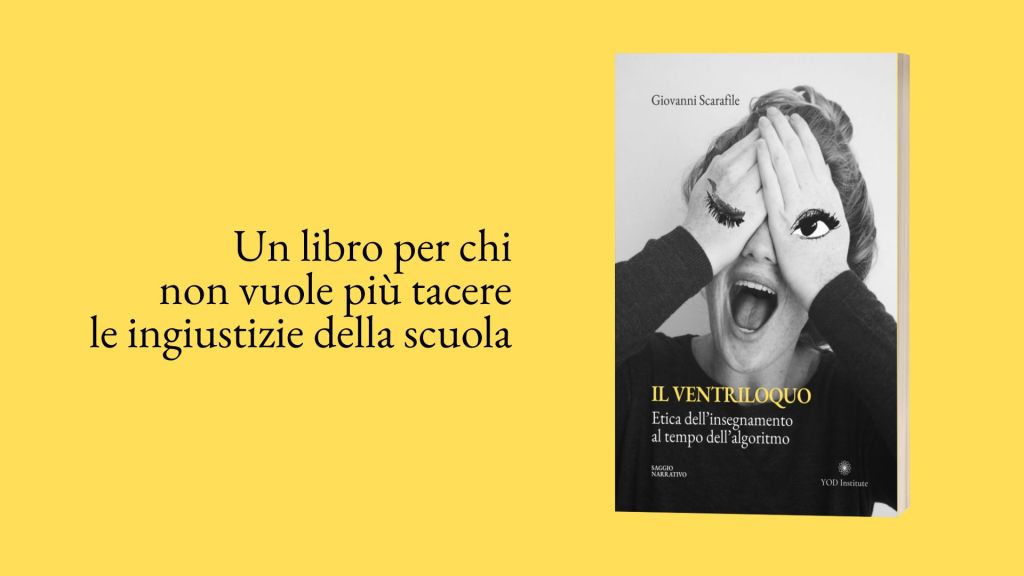
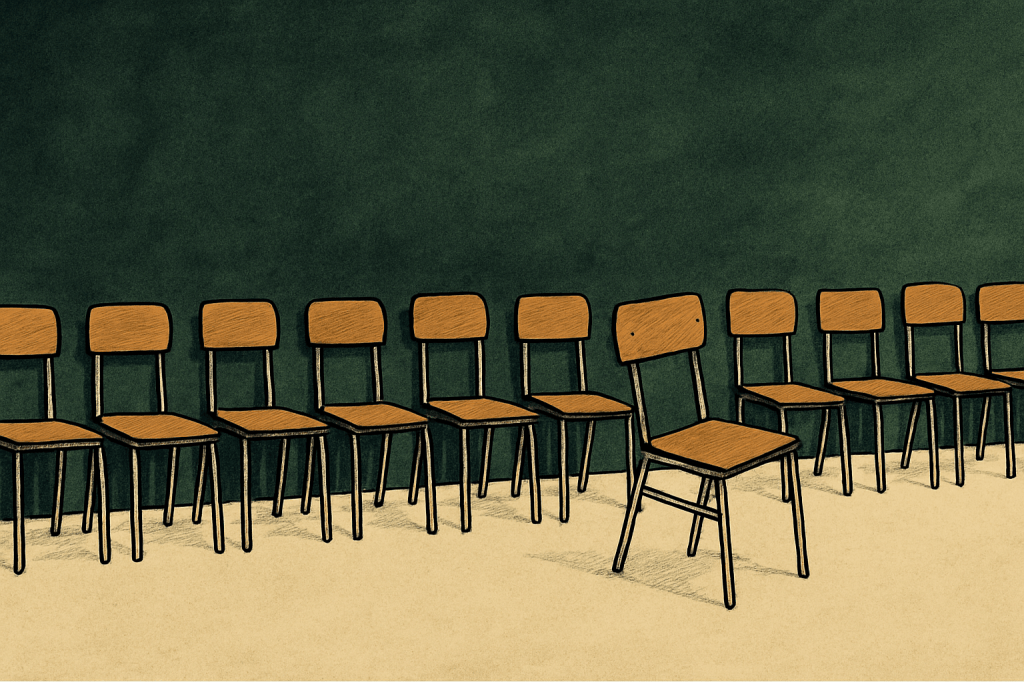
Lascia un commento