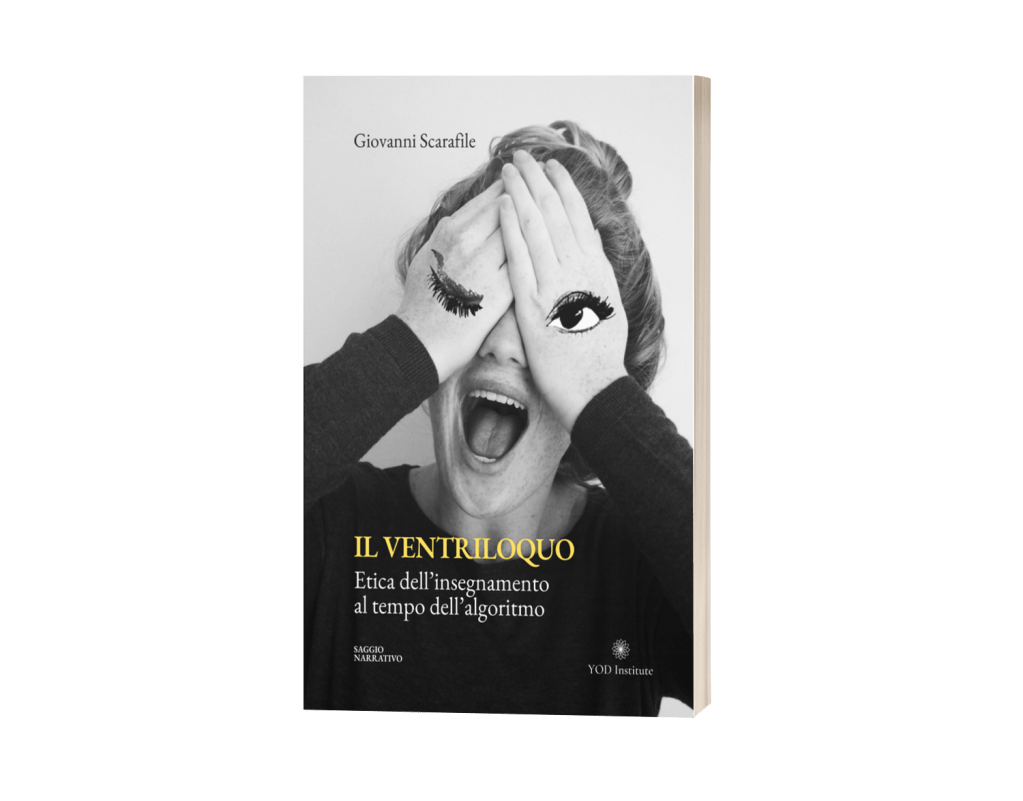(Questa parte è un estratto della Introduzione del libro)

Wer, wenn ich schriee, hörte mich
denn aus der Engel Ordnungen?[1]
Rainer Maria Rilke
Il silenzio abitato: viaggio e dignità
Nel 2019, dopo aver vinto il concorso all’Università di Pisa, non potendo ancora trasferirmi nella città toscana per motivi familiari, ogni lunedì partivo da Lecce, nel buio fitto della notte. Alle 3.30 lasciavo casa, la città ancora silenziosa, le luci dei bar chiusi, i lampioni che sembravano custodire i pensieri di chi non dorme. Il rumore secco e cadenzato delle scarpe sulle chianche leccesi rompeva appena quel silenzio compatto, come un segnale discreto che il giorno, da qualche parte, stava iniziando. Un treno mi portava a Bari, poi un altro fino all’aeroporto, e da lì un volo per Pisa. Alle 8.30 ero già in aula, pronto per fare lezione.
Di settimana in settimana, su quel treno per Bari, ho cominciato a riconoscere altri volti. Erano giovani, molto più giovani di me. Si salutavano tra loro con discrezione, si sedevano vicini, tiravano fuori delle copertine da viaggio. Dormivano come potevano, appoggiati ai finestrini, col capo reclinato. Lì per lì li avevo presi per pendolari qualunque. Ma lunedì dopo lunedì, ho capito: erano insegnanti. Precari, supplenti, che partivano dal sud della Puglia per andare a insegnare nei paesi del nord barese o addirittura nel foggiano – circa 350 chilometri solo per l’andata, quasi 700 tra andata e ritorno. Lo facevano ogni giorno.
Il controllore, che conosceva quella comunità silenziosa meglio di me, spesso passava oltre senza chiedere i biglietti. Per non svegliarli. Io, che pensavo di aver raggiunto un estremo con le mie levatacce alle 3 del mattino, mi rendevo conto che davanti a me c’era una realtà ancora più aspra. Quei giovani affrontavano ore di treni, entravano in classe, insegnavano, e non potendo permettersi un alloggio vicino alla scuola, tornavano a casa dopo le nove di sera. Ogni giorno. In silenzio. Senza proteste. Senza titoli di giornale.
Ciò che mi rimaneva impresso non era soltanto la fatica di quei corpi, piegati da viaggi interminabili e da giornate di lavoro che cominciavano e finivano nel buio. Era, piuttosto, il silenzio. Un silenzio pieno, abitato, come quello che si sente nelle prime ore dell’alba, quando la città ancora dorme ma qualcosa, da qualche parte, è già in movimento. Quelle voci c’erano, ma non arrivavano a destinazione. Non per mancanza di forza, ma per mancanza di ascolto.
Dare voce è un gesto che ha una sua dignità intrinseca: non è un atto di generosità, ma un dovere. Chi ha una voce e non può usarla non è muto: è reso muto. Perché la voce è molto più di un suono: è il prolungamento della nostra presenza nel mondo, il modo in cui il nostro essere si fa riconoscere. Per questo, togliere a qualcuno la possibilità di parlare — o di essere ascoltato — è una forma sottile, ma radicale, di esclusione.
Ascoltare una voce significa accettare di lasciarsi raggiungere da un’altra esistenza. È, come ha osservato Hannah Arendt, abitare lo stesso mondo senza pretendere di essere l’unico a nominarlo. La filosofa tedesca, parlando dello spazio pubblico, ricordava che esso esiste soltanto se le persone possono apparire l’una all’altra con la propria voce, senza mediazioni che le snaturino. In questo senso, la voce è un fatto politico prima ancora che un fatto acustico: è ciò che ci salva dall’essere ombre mute in un mondo parlato da altri.
Troppo spesso, però, al posto della voce autentica si preferisce una voce sostitutiva, più docile, più funzionale.
È questa la matrice di ogni ventriloquio: qualcuno parla per te, dice ciò che dovresti dire, ma lo dice con parole che non ti appartengono. La tua esperienza resta lì, imprigionata dietro un diaframma invisibile. Da fuori sembra che tu abbia parlato, ma in realtà sei rimasto in silenzio. È un inganno antico e raffinato, che non ha bisogno di censura esplicita: basta sostituire la parola viva con una parola delegata.
L’antidoto a questa condizione non è semplicemente “dare la parola”, ma dare spazio all’ascolto. Un ascolto che non interrompe, che non traduce subito in sintesi, che non corregge l’accento per renderlo più presentabile. Ascoltare significa stare nella distanza che separa la nostra voce da quella dell’altro, riconoscendo che in quella distanza c’è la possibilità di un incontro reale.
Quando penso a quei viaggiatori del treno per Bari, mi rendo conto che il silenzio in cui erano immersi non era un vuoto: era colmo di racconti, di paure, di piccoli trionfi quotidiani. Bastava sedersi accanto e chiedere, e allora la voce usciva, e nel suo suono si sentiva la stanchezza, ma anche la dignità di chi continua a fare il proprio lavoro senza chiedere applausi.
La voce, quando viene ascoltata, rompe l’incantesimo del ventriloquio. Restituisce alla persona il proprio posto nella trama del mondo. E ci ricorda che la storia di ciascuno è irripetibile, e che perderla equivale a perdere un frammento di umanità.
Questo libro nasce così: per far risuonare le voci che altrimenti resterebbero chiuse in un silenzio imposto, e per ricordare che ogni volta che diamo ascolto a una voce, spezziamo un’ombra e facciamo entrare un po’ di luce.
Il grido senza destinatario: sull’invisibilità della voce degli insegnanti
«Chi, se gridassi, mi ascolterebbe, dunque, dalle gerarchie angeliche?», il verso di Rilke scelto come esergo di questa Introduzione si riferisce ad un “gridare” non come semplice atto fisico, ma come urlo dell’anima, un appello estremo lanciato verso un ordine dell’essere radicalmente altro, che rischia di non essere mai udito o compreso. È un grido che, per la sproporzione tra chi lo emette e chi dovrebbe ascoltarlo, nasce già nella consapevolezza della sua impotenza. Quel verso può essere assunto come omaggio a tutti coloro la cui voce non trova ascolto.
Non si tratta, nel caso di questo libro, di un richiamo rivolto a entità sovrumane, ma a un mondo fin troppo umano, spesso indifferente, che si sceglie di non sentire. Penso, appunto, ai professori e alle professoresse che, nella penombra di un’alba che non conosce ancora il giorno, salgono su treni diretti verso scuole lontane. Portano con sé libri, compiti da correggere, lezioni da preparare, ma soprattutto una voce: la voce della propria esperienza, della propria fatica, della propria dedizione.
Eppure, questa voce raramente oltrepassa le pareti dell’aula. Non raggiunge i luoghi dove si decidono le sorti dell’istruzione, non si insinua nei discorsi ufficiali, non trova spazio nelle narrazioni pubbliche. Resta confinata al mormorio delle conversazioni tra colleghi, alla confidenza scambiata in un corridoio, o, peggio, si spegne nel silenzio rassegnato di chi sa di non essere ascoltato.
In questo senso, il “gridare” di Rilke diventa la metafora perfetta della condizione di questi insegnanti. Non gridano per mancanza di forza, ma perché sanno che il destinatario, pur vicino, vive in un ordine di priorità che esclude la loro voce. Il loro grido non si perde nell’infinito, ma si frange contro un sistema che li osserva senza ascoltarli.
Richiamare il verso di Rilke significa dunque sottrarre queste voci alla loro invisibilità e riconoscerle come parte essenziale della nostra comunità civile. È un atto di restituzione: riportare nel registro dell’ascolto quelle presenze che il discorso pubblico tende a ignorare, e che pure, nel silenzio di un viaggio notturno, custodiscono la sostanza viva dell’educazione.
Ingiustizia passiva e silenzio pubblico
La seguente domanda non sembri una digressione insolita rispetto al tema di cui stiamo discutendo: a che cosa pensiamo quando parliamo d’amore? Potremmo rispondere: alla forza che unisce, alla promessa di fedeltà, alla speranza di compimento reciproco. L’amore, nella sua dimensione più alta, è legame, dedizione, dono. Eppure, potrebbe mai esistere l’amore senza il tradimento? Senza l’ombra che lo accompagna e ne rivela la fragilità? Pensate all’Otello di Verdi: lì il tradimento non è un episodio marginale, ma la struttura stessa del dramma. È l’inganno di Iago, che tradisce l’amicizia fingendo lealtà; è il tradimento immaginato da Otello, che accusa Desdemona di infedeltà senza che vi sia colpa; è infine il tradimento di Otello verso se stesso, quando lascia che la gelosia e la menzogna prevalgano sulla fiducia e sulla ragione. In questo intreccio, il tradimento non appare soltanto come la negazione dell’amore, ma come ciò che ne mette in risalto la serietà e la precarietà. L’amore senza la possibilità del tradimento resterebbe un idillio senza spessore, incapace di generare tragedia, arte, pensiero.
Torniamo a noi: la postura con cui la nostra tradizione filosofica ha pensato la giustizia è stata di conferirle la piena dignità di un’idea normativa, relegando invece l’ingiustizia a una posizione subordinata, quasi fosse un accidente, una semplice privazione. Se l’arte, nel trattare l’amore, ha saputo riconoscere al tradimento un proprio statuto drammatico, la filosofia, al contrario, ha spesso trascurato l’ingiustizia come oggetto autonomo di riflessione. Ne ha fatto il rovescio di un ideale, una nota a margine rispetto alla melodia principale. Eppure, come il tradimento è ciò che dà spessore all’amore rendendolo tragico e reale, così l’ingiustizia è ciò che segna in profondità le vite delle persone e delle comunità, e non può essere ridotta a un’ombra marginale.
Per indicare tale postura vorrei parlare di “idealizzazione normativa”. In base a questo processo, la giustizia è elevata a figura regolativa che indica ciò che dovrebbe essere. Aristotele, con la sistematizzazione della giustizia distributiva e correttiva, ha fissato in maniera esemplare questa struttura di pensiero: la giustizia è l’ordine che assicura a ciascuno il suo, secondo proporzione o uguaglianza, e diventa così la categoria che consente di leggere la vita politica come ordinamento razionale. Questa impostazione ha avuto una fortuna straordinaria, attraversando epoche e scuole, fino a costituire il comune denominatore tanto del pensiero medievale, che la innesta sul piano della legge divina, quanto dei moderni contrattualismi, che la declinano come esito del patto sociale, e persino delle varianti liberali e utilitaristiche, che la assumono come criterio di efficienza e di benessere collettivo.
L’esito è che intere biblioteche filosofiche si sono accumulate sul concetto di giustizia, mentre l’ingiustizia resta in ombra, evocata solo come negazione o difetto.
In anni recenti, Judith Shklar, filosofa politica ad Harvard e considerata tra le più influenti teoriche del liberalismo del Novecento, ha denunciato questo processo. Nel suo saggio Faces of Injustice, pubblicato nel 1990, ha posto in evidenza come la tradizione occidentale abbia costantemente privilegiato la costruzione di modelli ideali di giustizia, relegando l’ingiustizia a un ruolo meramente derivativo, «an unusual enterprise» [2], una semplice mancanza o negazione.
Ma, nota Shklar, così facendo si elude il compito di comprendere la forza propria dell’ingiustizia, la sua capacità di segnare la vita delle persone e delle comunità anche quando esistono istituzioni apparentemente solide.
Le osservazioni che precedono sono decisive se noi le riferiamo al campo educativo.
In effetti, quando parliamo di scuola, anche oggi, siamo tentati di disegnare la scuola ideale, di immaginare ciò che dovrebbe essere. Si parla di eccellenza, di innovazione, di merito, di equità. Ma molto più raramente ci si sofferma sui mali quotidiani della scuola, sulle sue ingiustizie ordinarie. La “idealizzazione normativa” diventa così un alibi che impedisce di affrontare i guasti reali (e, di conseguenza, di dare voce a coloro che lavorano in quelle situazioni).
Sto parlando di un meccanismo che opera in modo quasi automatico ogni volta che la scuola diventa oggetto di discorso pubblico. Si preferisce celebrare la promessa di una scuola che ancora non c’è piuttosto che prendere sul serio il malessere delle scuole reali, con i loro docenti isolati, i loro studenti disorientati, le pratiche burocratiche opprimenti, le differenze territoriali che si fanno strutturali.
L’“idealizzazione normativa” diventa così una forma sofisticata di rimozione collettiva. Non è un mero errore concettuale, ma un vero e proprio alibi che ci solleva dall’obbligo di affrontare i guasti reali, permettendoci di sostituire al disagio concreto la retorica del valore. In questo modo, invece di misurarci con l’ingiustizia, preferiamo consolarci con la visione rassicurante di una scuola che distribuisce opportunità in modo equo, che valorizza i talenti, che riduce le disuguaglianze. Si tratta di una rappresentazione non falsa in senso stretto, ma parziale e dunque fuorviante, perché orienta l’attenzione verso un ideale normativo e distoglie lo sguardo dalle asimmetrie effettive.
Se le cose stanno così, se il disconoscimento della voce dei docenti è così sistematico, come mai nessuno ne parla, come mai – in senso figurato – non ci sono le barricate? Anche se a questa domanda risponderò nel corso dell’intero libro, ci sono delle cause specifiche che possono essere indicate.
In particolare, c’è un aspetto del ragionamento di Judith Shklar che mi sembra particolarmente convincente, soprattutto se noi lo riferiamo al mondo della docenza. Parlando degli “ascriptive groups”, ovvero quei gruppi ai quali si appartiene non per scelta ma per nascita o per caratteristiche considerate innate – razza, genere, religione, origine sociale –, la filosofa americana spiega perché, nella realtà, gli stessi soggetti che subiscono l’ingiustizia spesso non la riconoscano come tale. Accade, osserva Shklar, che molti membri di questi gruppi interiorizzino la condizione di inferiorità che viene loro attribuita, arrivando talvolta a identificarsi con lo sguardo dell’aggressore e a ritenere meritato il disprezzo ricevuto. Altri, pur consapevoli delle discriminazioni, preferiscono negare di averne fatto esperienza diretta, quasi a difesa di un residuo di autostima. Altri ancora scelgono il silenzio come forma di protezione, perché riconoscersi pubblicamente come vittime significherebbe esporsi a un’ulteriore umiliazione.
Se trasferiamo questo ragionamento alla condizione degli insegnanti, possiamo cogliere un parallelismo significativo. Pur non essendo essi un gruppo “ascriptive” in senso stretto, i docenti finiscono spesso per subire dinamiche simili: la loro marginalizzazione sociale, l’eccesso di carichi burocratici, la precarietà diffusa vengono vissuti come tratti inevitabili della professione, al punto che molti preferiscono non nominarli come ingiustizia. Alcuni si convincono che “fa parte del mestiere”, altri minimizzano con la formula del “non posso lamentarmi più di tanto”, altri ancora rimuovono del tutto l’esperienza negativa per non sentirsi schiacciati dal peso del fallimento. Anche nel loro caso, dunque, la mancata percezione dell’ingiustizia non nasce da indifferenza ma da un bisogno di difesa: nominare il torto significherebbe ammettere di essere stati sconfitti, e questa ammissione è spesso insostenibile. «La maggior parte delle persone – osserva Shklar – odia pensare a se stessa come vittima; dopotutto, nulla potrebbe essere più degradante. Quasi tutti noi preferiremmo riorganizzare la realtà piuttosto che ammettere di essere oggetti impotenti dell’ingiustizia. Perfino l’autoinganno è preferibile al dover riconoscere la sconfitta» [3].
È, in effetti, un peso enorme, perché aggiunge sofferenza alla sofferenza: oltre al danno, anche la consapevolezza della propria impotenza. Per molti, questo è un carico insopportabile. È allora del tutto comprensibile che si scelga la via della rimozione o della minimizzazione. Si preferisce credere che non sia accaduto nulla di grave, che si tratti di un disguido passeggero, che le cose miglioreranno. Si preferisce andare avanti, “tirare a campare”, piuttosto che affrontare la verità di essere stati messi a tacere.
Nel caso degli insegnanti questo meccanismo non dipende soltanto da dinamiche psicologiche individuali, ma è amplificato dalla responsabilità del discorso pubblico che circonda la scuola. La narrazione dominante – politica, mediatica, culturale – esalta la scuola come luogo di missione, di speranza collettiva, di rigenerazione morale. In questo quadro, riconoscere nell’insegnante una vittima di ingiustizia significherebbe incrinare un’immagine simbolica che la comunità ha bisogno di preservare per rassicurare se stessa. La conseguenza è che lo spazio discorsivo in cui gli insegnanti potrebbero nominare i propri mali viene neutralizzato dall’esterno: se un docente denuncia la propria fatica o la propria marginalità, il rischio è che venga percepito come lamentoso, come colui che tradisce la narrazione condivisa del dover essere. Perciò il silenzio non è soltanto una scelta di prudenza, ma l’esito di una pressione collettiva che impedisce di riconoscere la vulnerabilità dell’insegnante. In questo senso, il discorso pubblico si fa corresponsabile del silenzio che Shklar descrive a proposito degli ascriptive groups: un silenzio imposto più che scelto, che nasce dal rifiuto comunitario di vedere nell’altro la vittima di un’ingiustizia, perché ciò significherebbe ammettere la propria corresponsabilità e rinunciare alla consolazione offerta dal mito della scuola come istituzione salvifica.
È proprio a questo livello che noi possiamo parlare di ingiustizia passiva (passive injustice). Si tratta di una nozione a cui la stessa Shklar dedica una sezione importante della sua riflessione e con cui si indica non l’ingiustizia compiuta attivamente da chi viola le regole, ma l’ingiustizia di chi, potendo intervenire, sceglie di non farlo. È l’ingiustizia di chi guarda altrove quando vede un torto, di chi si rifugia nell’indifferenza o nella scusa del “non è affar mio”. Nella tradizione repubblicana, nota Shklar, la passive injustice è una colpa civica gravissima, perché mina le basi della convivenza e dell’impegno comune.
Applicata al contesto scolastico, questa nozione mostra la nostra responsabilità collettiva verso gli insegnanti. Non è solo la politica scolastica, con le sue riforme mancate e i suoi carichi burocratici, a produrre ingiustizia. Siamo noi, come cittadini, che commettiamo passive injustice ogni volta che vediamo i docenti sopraffatti e non reagiamo. Ogni volta che consideriamo “normale” che passino ore a compilare documenti inutili. Ogni volta che sorridiamo con indulgenza quando un professore parla di burnout, come se fosse un’esagerazione. Ogni volta che, come genitori, pretendiamo il massimo senza chiederci quali condizioni rendono possibile quel massimo. Ogni volta che, come studenti, riduciamo il docente a un distributore di voti.
Il punto è che ogni volta che, per quieto vivere, distogliamo lo sguardo dal malessere degli insegnanti e preferiamo non sollevare la questione, ripetiamo esattamente quel meccanismo che Judith Shklar ha descritto con lucidità: «una delle ragioni per cui non esiste una cura per l’ingiustizia è che persino cittadini ragionevolmente onesti non ne desiderano una. Ciò non dipende da disaccordi su ciò che è ingiusto, ma dalla riluttanza a rinunciare alla pace e alla quiete che l’ingiustizia può, e di fatto sa, offrire» [4].
La passive injustice nei confronti degli insegnanti prende dunque la forma dell’abitudine. Ci abituiamo a vedere il loro malessere come se fosse parte del paesaggio. Ci rassicuriamo pensando che, in fondo, si tratta di una professione stabile, di un lavoro sicuro con tre mesi di ferie pagate all’anno… Dimentichiamo che la sicurezza formale può convivere con una profonda precarietà esistenziale, fatta di mancanza di ascolto, di isolamento, di invisibilità. Come osserva Shklar, la passività non è un peccato di omissione innocente: è una forma di complicità. E questa complicità, nel caso della scuola, riguarda l’intera comunità civile.
È precisamente in questa prospettiva che si colloca la scelta metodologica che attraversa il libro: intrecciare l’analisi dei processi con la narrazione delle esperienze personali. Non si tratta di un espediente letterario secondario, ma di una vera e propria strategia conoscitiva. Ogni capitolo saggistico è introdotto da una parte narrativa che porta con sé le voci di tre figure finzionali, accomunate dall’essersi conosciute a Pisa, nella seconda metà degli anni Sessanta, nel clima intellettuale che segnava allora la vita universitaria.
Leggeremo così le pagine di diario di Bianca, che scrive al suo autore prediletto, Alessandro Manzoni, chiamandolo per nome e intrecciando alle difficoltà della sua vita scolastica il bisogno di tenere viva la propria passione letteraria. Seguiremo i monologhi interiori di Ines, filosofa ribelle e disincantata, che attraversa la scuola con lo sguardo critico di chi non si rassegna all’opacità burocratica. E incontreremo le email di Ruggero, matematico della Normale, che scrive da Birmingham, dove insegna, alle due compagne di un tempo, raccontando la fatica e le contraddizioni dell’insegnamento in un sistema attraversato da standard e ispezioni.
Queste tre voci non sono un divertissement, ma costituiscono un dispositivo narrativo che si intreccia con l’analisi teorica, generando una forma espressiva ibrida, volutamente densa. L’alternanza di saggio e racconto è ciò che permette di vedere con maggiore nitidezza le forme ordinarie e persistenti dell’ingiustizia che attraversano la scuola, e che il discorso pubblico tende a occultare dietro la retorica della missione o della speranza collettiva. In questo senso, la scelta di dare spazio a Bianca, Ines e Ruggero non risponde a una esigenza ornamentale, ma a una precisa convinzione metodologica: solo l’intreccio tra la voce analitica e la voce narrata consente di restituire l’interezza del fenomeno.
Dalla scelta di fare ricorso, sulla scia di Merleau-Ponty, a forme di espressione ibride è discesa la necessità di un ribaltamento di prospettiva: non partire dall’ideale di una “scuola giusta”, ma dall’analisi puntuale delle sue ingiustizie effettive, colte dall’interno da parte di coloro che le subiscono, dato che, «Se non si tiene pienamente conto della loro esperienza, il quadro dell’ingiustizia resta incompleto»[5].
Tanto più si riesce a restituire la concretezza vissuta di queste ingiustizie, tanto più l’analisi critica diventa incisiva. In tal senso, dare all’ingiustizia il suo dovuto non è un artificio teorico, ma un compito politico e morale: è l’unico modo per spezzare l’inerzia di un discorso pubblico che celebra la scuola come istituzione redentrice mentre lascia i suoi attori concreti in una condizione di marginalità e isolamento.
[…]
Scenario e metodo
Prima di concludere questa Introduzione, ci sono tre precisazioni da fare.
1. In ciò che seguirà, la scuola – ed, in particolare, la scuola italiana – costituisce lo scenario privilegiato di analisi. È qui che le dinamiche che descrivo emergono con maggiore evidenza e dove trovano il loro terreno più concreto di osservazione. Tuttavia, ciò che metto in luce non riguarda soltanto la scuola: le stesse logiche sono attive, con modalità spesso analoghe, anche nelle università e nel mondo della ricerca. Non si tratta dunque di fenomeni circoscritti a un contesto nazionale né a un unico livello di istruzione. Al contrario, le stesse tendenze si riscontrano in molte altre realtà educative, come dimostra la bibliografia internazionale a cui faccio riferimento e che attinge in larga parte ad autori di lingua inglese. Questa precisazione è necessaria, poiché il libro viene pubblicato contemporaneamente in italiano e in inglese, e intende situarsi da subito entro un orizzonte di riflessione che è insieme locale e globale.
2. La riflessione che segue si colloca deliberatamente sul piano etico. Non riguarda metodologie didattiche o modelli formativi, ma i presupposti di responsabilità, di giustizia e di riconoscimento che sorreggono ogni istituzione educativa. La scuola, in questo senso, va considerata come un bene pubblico: non un semplice apparato tecnico deputato alla trasmissione di conoscenze, ma una forma di vita collettiva in cui si riflette la qualità della nostra convivenza e il grado di responsabilità che una società è capace di esercitare verso le generazioni future. A questa prospettiva etica si intreccia, inoltre, un richiamo all’antropologia filosofica, intesa come ricognizione dell’umano nella sua interezza: un’indagine che, pur non potendo essere sviluppata qui nei dettagli, verrà ripresa nell’ultimo capitolo, dove emergerà con maggiore chiarezza il nesso tra esperienza educativa e configurazioni fondamentali dell’essere umano.
3. Un’ulteriore precisazione riguarda il metodo seguito nel mio percorso di ricerca. Non ho cercato l’esaustività, né sarebbe stato opportuno: ciò che propongo nasce piuttosto dall’incontro con alcuni autori, che mi hanno convinto — a ragion veduta — della rilevanza del tema a cui pensavo da tempo. Orientarmi nelle bibliografie non è stato un esercizio di accumulazione, ma un lavoro di discernimento: cercare non chi avesse già detto tutto, ma chi fosse in grado di aprire la strada verso una comprensione più precisa.
Così, Stephen Ball mi ha aiutato a mettere a fuoco il nesso tra politiche educative e logiche neoliberali, mostrando come la scuola venga trasformata da luogo di formazione a dispositivo di performance. Miranda Fricker mi ha offerto strumenti per riconoscere le forme specifiche di ingiustizia epistemica che colpiscono i docenti, privandoli del loro statuto di soggetti di conoscenza. Judith Shklar, infine, con il suo “liberalismo della paura” e con l’attenzione all’esperienza dell’ingiustizia più che a quella della giustizia, ha reso possibile uno sguardo meno astratto e più vicino alle condizioni effettive della vita democratica. Infine, Gert Biesta ha contribuito in modo decisivo a chiarire la posta in gioco dell’educazione come pratica pubblica: la sua distinzione fra qualificazione, socializzazione e soggettivazione permette di comprendere che l’insegnamento non si riduce né alla trasmissione di competenze né all’adattamento a ruoli sociali, ma implica anche la formazione di soggetti capaci di libertà e responsabilità.
Sono questi riferimenti a introdurre con precisione i temi che affronto e a giustificare la scansione dei capitoli: dalla descrizione delle forme di marginalizzazione della voce docente, alla ricostruzione delle cornici epistemiche che ne rendono conto, fino al tentativo di delineare una risposta etica capace di ridare senso alla scuola come bene pubblico.
Il titolo Il ventriloquo. Etica dell’insegnamento al tempo dell’algoritmo intende racchiudere due linee interpretative che percorrono l’intero volume.
La figura del ventriloquo rimanda alla condizione dell’insegnante la cui voce è progressivamente sostituita o sovradeterminata da logiche esterne: egli sembra parlare, ma in realtà articola un discorso che non nasce dalla sua libertà, bensì da procedure, modelli e dispositivi che parlano per lui. È la condizione di chi non può esprimere pienamente la propria esperienza educativa, perché vincolato da un linguaggio burocratico che ne anticipa e ne esaurisce i margini.
Il riferimento all’algoritmo non va inteso in senso tecnico, ma simbolico. L’algoritmo rappresenta il dominio della performatività: la riduzione dell’insegnamento a dati, indicatori, output da misurare e confrontare. È il segno di un potere che definisce la qualità educativa non a partire dalla relazione viva tra docente e studente, ma in base a griglie di valutazione, parametri standardizzati, procedure uniformanti. L’algoritmo è quindi il nome di una razionalità che trasforma la scuola in apparato di sorveglianza e di controllo, in cui ciò che non è traducibile in numeri viene messo ai margini o ignorato.
Il titolo segnala così una tensione etica: l’insegnante non è chiamato solo a trasmettere contenuti, ma a preservare la possibilità di una voce propria, capace di resistere al ventriloquio delle procedure. La questione non riguarda soltanto la dignità professionale, ma la natura stessa della scuola come bene pubblico. Se gli insegnanti non possono parlare con la loro voce, a perdere non è soltanto la loro identità, ma la società nel suo complesso, che rinuncia alla possibilità di una trasmissione critica e libera del sapere.
In questo quadro, la denuncia non è un esercizio di risentimento, né un gesto retorico destinato a suscitare indignazione effimera. È un atto di responsabilità civica e di rigore analitico. Denunciare significa restituire alla scuola la sua verità non edulcorata, riconoscere la distanza fra le promesse ideali e le condizioni reali, ridare voce a chi è stato ridotto al silenzio. Per questo la dignità professionale non può essere pensata come un premio o come un riconoscimento opzionale: è la condizione minima senza la quale l’insegnamento si degrada in un ventriloquio, una voce che si muove senza ascolto, un lavoro che si regge senza riconoscimento, un mestiere che sopravvive senza rispetto.
Desidero anche segnalare che questo libro è stato concepito in concomitanza con l’avvio del sito ilventriloquo.prof, pensato come un luogo di approfondimento e di incontro. Non un semplice archivio digitale, ma un hub in cui raccogliere materiali aggiuntivi, documenti e testimonianze, e soprattutto un modo per continuare ad ascoltare le voci di chi nella scuola vive quotidianamente l’esperienza che qui ho cercato di restituire.
Nel concludere, vorrei infine fare ritorno ai volti dei docenti incontrati sui treni all’alba, piegati dalla stanchezza eppure tenaci nel portare avanti il loro lavoro lontano da casa, senza clamore e senza riconoscimento. È a loro che questo discorso deve tornare, perché da quelle vite silenziose prende forma la necessità stessa della denuncia.
Il Ventriloquo, nel suo alternarsi di analisi e narrazione, è dunque un tentativo di colmare la distanza tra chi guarda da fuori e chi vive dall’interno; tra chi studia e chi ogni giorno, senza clamore, regge il peso e la dignità del proprio mestiere.
Questo libro è dedicato a loro.
Lecce-Pisa
G.S.
[1] Rilke, R. M. (1923). Duineser Elegien. Leipzig: Insel-Verlag.
[2] Judith N. Shklar, The Faces of Injustice, Storrs Lectures on Jurisprudence, Yale Law School 1988 (Yale University Press, 1990), 15.
[3] Shklar, The Faces of Injustice, 38.
[4] Shklar, The Faces of Injustice, 45.
[5] Shklar, The Faces of Injustice, 35.